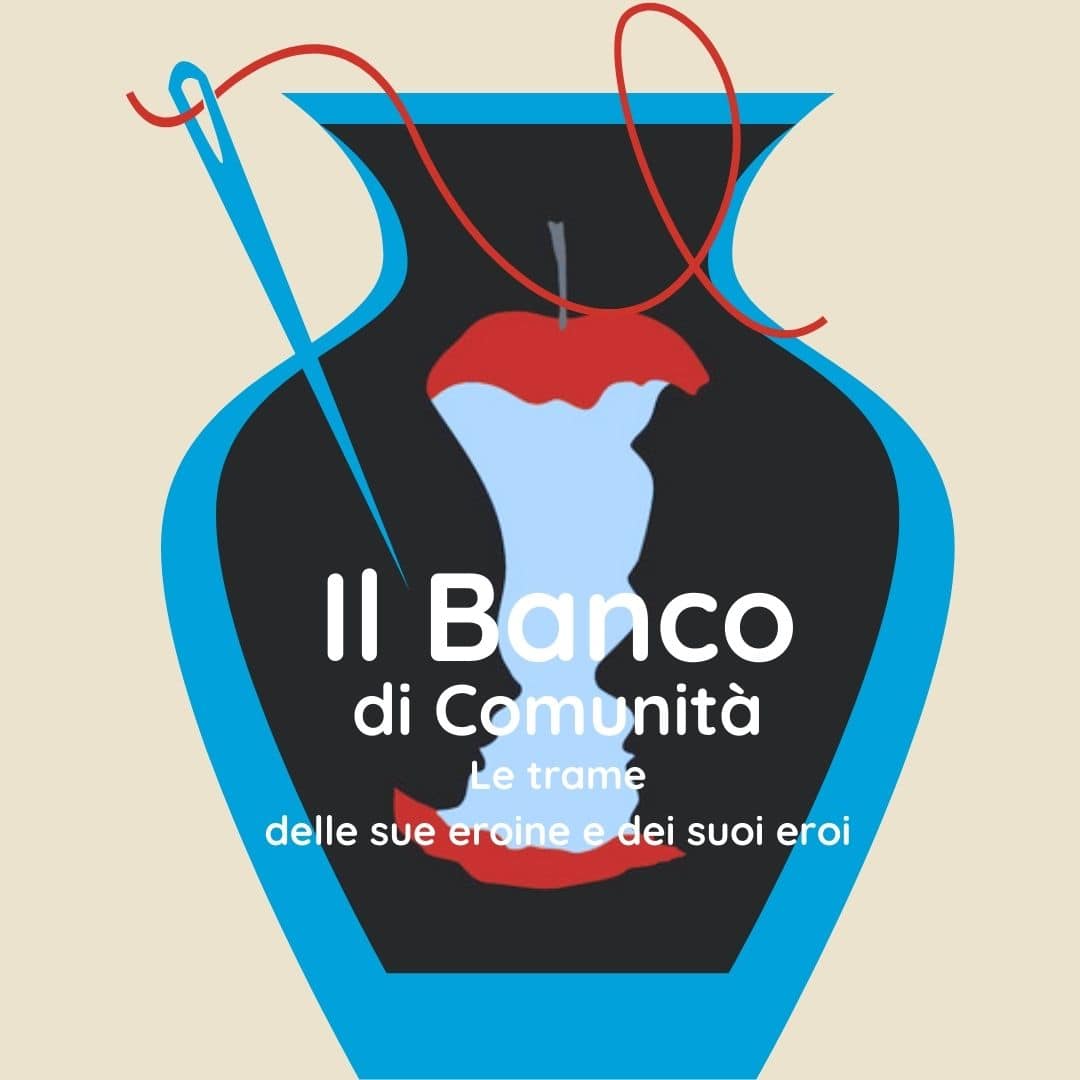Festival letterario internazionale di educazione sentimentale “La LEGGEREzza del male: navigare tra le emozioni” – Samatzai (SU)
Incontri con gli autori, reading letterari, conferenze informative ed educative.
III edizione settembre – novembre 2025
Raccontare di questa iniziativa è una necessità: non solo perché nel programma sarò fra gli ospiti, non solo perché l’avventura della Sardegna continua e anzi si rinnova; ma perché l’intera estate è stata una mia ricerca personale intorno proprio all’aporia del male o – come diceva Hannah Arendt – alla banalità del male.
Il titolo di questo festival non poteva che essere più calzante, un ossimoro di parole che il nostro cervello registra come impossibili da affiancare, eppure nella vita di tutti i giorni molto spesso camminano a braccetto: leggerezza e male.
Le cose non avvengono mai per caso, e anche se l’invito a partecipare è giunto agli inizi dell’estate, non avrei mai pensato che l’intera stagione mi vedesse protagonista di riflessioni così dense intorno a questi concetti. È stata dunque un’urgenza partecipare a questa iniziativa: sento il bisogno impellente di condividere a voce alta quello che sfugge al nostro controllo.
Vi starete chiedendo cosa è accaduto questa estate di così significativo; ebbene, sono stata coordinatrice di un centro estivo, la cui fascia d’età ammessa andava dai 6 ai 14 anni. Una fascia d’età dove si è ancora bambini, si inizia ad entrare nella pre-adolescenza, dove il gioco fine a se stesso dovrebbe ancora riempire le giornate di questi minori di età. Tuttavia qualcosa ha stonato in tutto questo e da professionista non ho potuto girarmi dall’altra parte.
Sulla bocca di tutti quei bambini e quelle bambine c’era una moda, la moda della serie tv Netflix Squid Game. Una moda in effetti un po’ in ritardo rispetto all’uscita della serie, la maggior parte degli adulti (eccetto me) l’aveva già terminata qualche anno prima, però ai bambini è giunta a scoppio ritardato. La serie tv in realtà è vietata ai minori di 16 anni (e vorrei ben vedere!), io mi ero per principio rifiutata di vederla, ma quando le dinamiche violente hanno riguardato da vicino i bambini di cui mi prendevo cura, non mi sono più potuta tirare indietro.
Questa cosa mi ha particolarmente toccata, ancor prima di iniziare le prime puntate. Sono riuscita a terminare tutte le stagioni con grande difficoltà e ponendomi ogni giorno degli interrogativi. I miei studi del passato sono riemersi, le riflessioni sulla banalità del male o sull’omologazione e la depersonalizzazione. Oggi come allora la visione di certe scene, la visione di una morale quanto mai contemporanea di normalizzazione della violenza mi ha sconvolta.
Ecco un altro ossimoro: abbinare a bambini e bambine così piccoli un’esposizione di violenza di quel tipo. Ecco che qui partono altri infiniti pensieri che talvolta possono sembrare banali, ridondanti e scontati. Forse però se continuano a spiazzarci è perché non sono stati ripetuti a sufficienza.
Consiglio a chi non avesse avuto modo di vedere la serie tv, di non proseguire nella lettura, in quanto potrebbe presentarsi una forma di spoiler di alcuni elementi; la prima stagione realizza una chiara polemica nei confronti della società della Corea del Sud. Indebitamenti, netta separazione tra ricchi e poveri, un senso della vita sfumato perché meglio morire che sopravvivere come miserabili. Dei ricchi che non sanno come impiegare il proprio tempo perché, novità assoluta, i soldi non fanno la felicità. Solo sul finire si insinua un argomento prettamente umano: davvero l’altruismo è stato completamente cancellato dalla faccia della terra? La seconda stagione tenta di dare una risposta, ambientata però in un tempo contemporaneissimo: i giocatori sono giovanissimi, spesso influencer falliti, si sente parlare di bit coin, e si verifica una netta separazione generazionale tra gli adulti e i giovani adulti, con punti di vista opposti.
La violenza diviene sempre più una risposta a qualsiasi problema, la soluzione per eccellenza, appunto normalizzata. Ora faccio un passo indietro per chi non avesse mai visto la serie tv. La trama di Squid Game ruota attorno a 456 persone indebitate che, per disperazione economica, partecipano a un misterioso torneo clandestino di giochi per bambini con un enorme montepremi. Il protagonista, Seong Gi-hun, si ritrova coinvolto in questa competizione mortale, dove chi perde viene eliminato nel senso letterale del termine, cioè ucciso. La serie, come già detto, è una critica della società, che esplora temi di disuguaglianza sociale, avidità, dilemmi morali e la lotta per la sopravvivenza in un sistema che premia i più forti e mette a dura prova l’umanità dei partecipanti. Qui potete già estrapolare le ulteriori riflessioni che si sono presentate davanti a me e che ancora ora non hanno trovato risposta, ma in qualche maniera si sono placate dal fatto di sapere di poter essere condivise a un festival così importante.
Fino a che limite si è umani? La parola “eliminato” nel gioco assume tutto un altro significato, che in realtà è sempre stato quello; ma allora cosa insegna il gioco ai bambini? Il problema sono davvero i giochi in sé? Come è possibile che i soldi ci influenzino fino a tal punto? C’è ancora speranza? Soprattutto, che cosa giunge alla mente dei minori di età esposti a tutto questo?
La cosa di cui preoccuparsi è sicuramente quella di lasciare letteralmente soli questi bambini davanti a scene lontanissime dalla loro comprensione, che a differenza di videogiochi, appaiono assolutamente quotidiane. La realtà e la fantasia non hanno mai avuto confini netti, ma qui non hanno davvero più alcuna distinzione.
Non ho qui la presunzione di esaurire tutti gli argomenti che ho appena lanciato come un sasso nello stagno. Spero che qualche onda concentrica vi possa sfiorare e non posso far altro che invitarvi a questo Festival, se passate dalla Sardegna: merita davvero. E una cosa la desidero aggiungere: quando non riuscivo a far fronte alla mia disperazione di questi argomenti per me così sensibili da non vederci via d’uscita, una persona a me molto vicina mi ha risposto che se perpetuiamo queste proposte non riusciremo a vedere la luce in fondo al tunnel; la vera soluzione è offrire a questi giovanissimi delle alternative. Il pessimismo è il contrario della vita e riporto alcuni passaggi di Miguel Benasayag, tratti dalla rivista Animazione Sociale.
Pessimismo significa dire: io sono l’ultimo uomo, sto vivendo la fine dell’umanità, con me il mondo andrà a scomparire. Lo trovo un godimento pazzo e malsano, perché il pessimismo è un godimento: perché significa avere una certezza, la certezza del peggio. Le sfide dell’epoca si manifestano concretamente in ogni situazione e sempre il passaggio da fare è pensare i problemi non come “io ho un problema”, ma come “noi abbiamo un problema”. Questo vale in ogni ambito: vale per l’esposizione dei nostri figli agli schermi digitali che ci preoccupa, vale per la violenza alle donne che non è mai solo questione di coppia. Serve liberare un agire gioioso: ad esempio, nell’educazione dei bambini non è la stessa cosa educarli a funzionare o a esistere, a usare il potere contro gli altri o a creare relazioni di collaborazione, lasciarli intrappolati negli schermi digitali o aiutarli a sviluppare il pensiero complesso […].
Qui vi lascio una bibliografia e sitografia affrontata nei mesi scorsi:
- Ethos della violenza videoludica di Elena Del Fante
- Il ruolo e l’importanza della violenza esplicita nei videogiochi: come viene percepita dai giocatori abituali, occasionali e dai non giocatori di Isabel Mercedes Parini
- L’effetto Lucifero di Philip Zimbardo
- La banalità del male di Hannah Arendt
- Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie
- https://filosoficamentelab.com/squid-game-letica-in-gioco/
- https://www.sullorlodellapsicologia.it/effetto-lucifero-esperimento-carcere-stanford/
- https://www.edugamers.cloud/post/videogiochi-come-causa-di-violenza-facciamo-chiarezza
- https://www.lachiavedisophia.com/squid-game-spietatezza-morale/